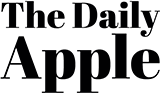Gli alimenti fermentati esistono da secoli. Sono presenti nelle cucine di tutto il mondo, dai mercati alle tavole, fino ai ristoranti. Oggi se ne contano circa 5.000 varianti. Costituiscono tra il 5% e il 40% delle diete mondiali. La fermentazione è un processo che coinvolge la crescita microbica e la conversione enzimatica dei componenti alimentari.
Gli alimenti fermentati nascono da questa trasformazione, che semplifica i nutrienti complessi in forme più accessibili, alterando il gusto, la consistenza e la conservabilità dei prodotti. Il processo permette di produrre formaggi, crauti, yogurt, salumi, vino, birra, kombucha, cioccolato, miso, salsa di soia, e molti altri. Questi prodotti variano da regione a regione.
In Francia si trovano yogurt, formaggi, crème fraiche e salsicce secche. In Giappone il natto e la pasta di miso. In Europa orientale il kefir e il kvas. In Etiopia l’injera. In Corea il kimchi, in El Salvador il curtido, in Germania i crauti. In India l’handvo, in Indonesia il tempeh, nelle Filippine il balao-balao, in Svezia il surströmming.
Gli alimenti fermentati si dividono tra quelli che mantengono microbi vivi e quelli che non lo fanno. Il pane a lievitazione naturale, ad esempio, perde i microrganismi durante la cottura. Anche i prodotti pastorizzati, come il sidro, non conservano batteri vivi. Tuttavia, anche senza microrganismi vivi, questi alimenti possono offrire benefici nutrizionali derivanti dai composti prodotti nel processo di fermentazione.
I moderni sistemi di conservazione hanno reso la fermentazione non più necessaria per prevenire il deterioramento, ma questi alimenti sono ancora apprezzati per le caratteristiche sensoriali e per la loro sostenibilità. La fermentazione aiuta a ridurre gli sprechi, allunga la durata dei prodotti e permette di riutilizzare ingredienti eccedenti o imperfetti.
Alimenti fermentati: come avviene il processo di fermentazione
La fermentazione è un processo biologico regolato. I microrganismi coinvolti sono batteri, lieviti o muffe. Questi trasformano carboidrati e altri nutrienti in sottoprodotti come acidi organici o alcoli. I batteri lattici convertono zuccheri in acido lattico, che conferisce ai prodotti fermentati sapori tipici.
Il lievito trasforma gli zuccheri in etanolo e anidride carbonica. Questo è il meccanismo alla base della produzione di vino, birra e idromele. Alcuni processi sono simbiotici: lieviti e batteri operano insieme, come nella kombucha, nel kefir, nell’aceto e nel pane a lievitazione naturale. Anche le muffe, in presenza di ossigeno, umidità e calore controllati, possono fermentare: il risultato è il formaggio erborinato, il tempeh, il miso e la salsa di soia. In questi casi interviene il koji, una muffa impiegata nella cucina giapponese.
La fermentazione modifica radicalmente l’alimento originario, agendo su consistenza, colore, gusto e profilo nutrizionale. Consente inoltre di trasformare cibi deperibili in alimenti conservabili per mesi, contribuendo alla sicurezza alimentare e alla riduzione dello spreco.
Alimenti fermentati: effetti sulla salute e sul microbioma intestinale
Il consumo di alimenti fermentati può influenzare il microbioma intestinale, ovvero la comunità di microrganismi che abitano l’intestino umano. Mangiare cibi fermentati con microrganismi vivi può aumentare la diversità microbica intestinale. Una maggiore diversità microbica è associata a una maggiore resilienza dell’intestino e a una migliore capacità di adattamento ai cambiamenti della dieta o agli antibiotici, prevenendo la disbiosi.
Oltre agli effetti sul microbioma, alcuni alimenti fermentati contengono peptidi bioattivi e molecole con proprietà antiossidanti. Le olive fermentate, ad esempio, sono ricche di polifenoli, vitamina E, grassi monoinsaturi e idrossitirosolo, e possono contribuire a ridurre il rischio cardiovascolare. Alcuni studi collegano il consumo di latticini fermentati come yogurt, kefir e formaggio a una riduzione del rischio di diabete di tipo 2. È stato anche osservato un miglioramento della composizione corporea, una riduzione del colesterolo e una minore incidenza di malattie cardiovascolari. Ogni 10 grammi di formaggio consumato al giorno si osserva una riduzione del 2% del rischio cardiovascolare. Tuttavia, servono ulteriori ricerche per confermare tali dati.
Gli alimenti fermentati possono anche migliorare la tolleranza al lattosio e facilitare la digestione. Alcuni studi dimostrano che il pane a lievitazione naturale è meglio tollerato da chi soffre di sindrome dell’intestino irritabile. Il processo può aumentare la disponibilità di vitamine del gruppo B e migliorare la digeribilità delle proteine. I prodotti a base di soia fermentata, come il tempeh e il natto, riducono la presenza di sostanze antinutrizionali, facilitando l’assorbimento dei nutrienti.
Alimenti fermentati: sicurezza alimentare e regole per il consumo domestico
Gli alimenti fermentati presenti nei supermercati devono rispettare le stesse norme di sicurezza di qualsiasi altro alimento. Il Regolamento CE 178/2002 richiede che siano sicuri per il consumo. La fermentazione può contribuire alla sicurezza alimentare inibendo la crescita di microrganismi patogeni. Tuttavia, una contaminazione può avvenire per scarsa igiene o cattiva conservazione. È quindi importante seguire le buone pratiche: lavarsi le mani, utilizzare utensili puliti, conservare i prodotti correttamente e rispettare la data di scadenza.
Alcuni cambiamenti sono fisiologici, come la comparsa di muffe nel formaggio erborinato, ma una crescita eccessiva o colorazioni anomale sono segnali di deterioramento. Nel caso della fermentazione casalinga è fondamentale usare ricette collaudate, risciacquare gli ingredienti e assicurarsi di ottenere un’acidità adeguata per garantire la sicurezza del prodotto finale.
Raccomandazioni e prospettive future
Gli alimenti fermentati non sono ancora formalmente inclusi nelle linee guida alimentari dei diversi Paesi, nonostante i benefici osservati. Alcuni esperti propongono di integrarli nelle raccomandazioni ufficiali per promuovere una dieta più consapevole e diversificata. Il progetto DOMINO, finanziato dal programma Horizon Europe, studia come questi alimenti influenzino il microbioma intestinale e possano aiutare soggetti con sindrome metabolica. Per definire meglio le raccomandazioni sarà necessario approfondire il ruolo della diversità microbica nella prevenzione delle malattie.
Introdurre nella dieta quotidiana cibi fermentati può avvenire con piccoli cambiamenti. Si può aggiungere yogurt nei frullati, consumare miso o crauti a pranzo, scegliere pane a lievitazione naturale o bere kefir. Il risultato è un’alimentazione più varia, sostenibile e potenzialmente benefica per l’organismo.