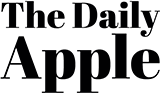L’arte potrebbe nascere da un bisogno umano di reazione al male, per renderlo più accettabile possibile. Non esprime il dolore, ma lo reinterpreta. Potrebbe nascere dall’angoscia, perché è l’unica che la comprende. Sarà per questo che il poeta francese Charles Baudelaire diceva che le forme artistiche erano tra i pochi modi per sfuggire al dolore esistenziale.
Depressi, angosciati, malinconici: la storia dell’arte, della letteratura e della musica è piena di capolavori realizzati da artisti sofferenti. L’opera “L’urlo” di Edvard Munch, ad esempio, esprime il disagio dell’artista, tormentato dalla perdita della madre e della sorella durante l’infanzia. Frida Kahlo, invece, ha iniziato a dipingere a sei anni, quando venne colpita da una polmonite. I musicisti che soffrivano di depressione sono tantissimi, tra cui Beethoven, Mozart, Rossini, Berlioz, Paganini, Ciajkovskij e Shostakovic. Sebbene l’arte non nasca solo dalla sofferenza, l’infelicità è spesso una spinta verso la creatività.
Infelicità fa rima con creatività: la spiegazione scientifica
Già esponenti della psicanalisi come Sigmund Freud e Carl Gustav Jung avevano sottolineato il legame tra creatività e dolore, dovuto all’instabilità emotiva, che costituisce un tratto di personalità caratteristico dei nevrotici. “Il nevroticismo fungerebbe da substrato per un’instabilità motoria e ideativa che spingerebbe la persona a trovare strategie per superare i momenti di angoscia attraverso attività come dipingere, scrivere o suonare”, spiega Antonio Cerasa, neuroscienziato dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica (Irib) del Cnr.
In sostanza, maggiori sono i tratti di nevroticismo (ansia, depressione, vulnerabilità allo stress) maggiore sarà la propensione a compiere atti in grado di mitigare le emozioni negative. Al contrario, “quando il corpo è investito da emozioni positive, l’essere umano tende ad amplificare il piacere stando insieme agli altri”.
Contrariamente a quello che si pensa, continua l’esperto, “il dolore – nella sua accezione più globale – produce plasticità neurale, mentre la felicità si associa con la sensazione di piacere, che ci spinge a ripetere i comportamenti piacevoli” – e nelle forme patologiche innesca il meccanismo della dipendenza.
Il dolore ha invece un effetto biologico più complesso: per il cervello è un segnale di pericolo attraverso il quale stabilire se un evento sia o meno da evitare. “Questo si traduce in una nuova memoria (nocicettiva) che si innesta a livello dell’ippocampo e rimane con noi per il resto della vita. Dall’ippocampo la nuova memoria si dirama, creando una rete di legami con altre popolazioni neurali che servono a rendere il ricordo sempre più complesso, associandolo a una miriade di sensazioni o di simboli verbali. La complessità delle ramificazioni dei prolungamenti delle cellule nervose, è direttamente proporzionale all’intensità delle emozioni: maggiore sarà la rete neurale creata e minore sarà l’impatto negativo del ricordo. “È probabilmente per questo che il dolore si associa spesso con la creatività: scrivere, dipingere, suonare rappresentano la manifestazione di nuove abilità che servono a rendere meno nocivo il peso del ricordo”.
Il simbolismo di Frida. Non solo tristezza, ma anche passione

L’opera La colonna rotta (1944) di Frida Kahlo esprime in modo esplicito il simbolismo del dolore. I trattamenti con apparecchi ortopedici durati anni sono impressi in quest’opera. Infatti la creatività è un mezzo per elaborare il dolore. Inoltre, le terapie espressive come la pittura, la scrittura o la composizione sono anche modi per prendersi cura di sé e delle proprie emozioni. Così come ha fatto Frida Kahlo, facendo leva su ciò che viveva come una tortura, per alimentare la sua passione e la sua voglia di vivere.
Tuttavia, oltre alla sofferenza, una caratteristica che accomuna i grandi artisti è la passione. Molti corrispondono alla definizione di mente creativa di Howard Gardner: legata al mondo emotivo, che va oltre l’ordinario, assumendosi dei rischi e osando.
La creatività è un atto solitario. La tristezza e il dolore spingono l’artista a ritrovare se stesso. Tuttavia, se la sofferenza è un catalizzatore per l’espressione artistica, lo sono anche la paura, la felicità, la rabbia, lo stupore. Anche se il dolore compie attraverso l’arte una catarsi, una trasformazione.
In conclusione, gli esseri umani sono un insieme di luci e ombre, di emozioni contrapposte. “La sofferenza si può giustificare quando si trasforma nella materia prima della bellezza”, scriveva Jean-Paul Sartre.