Chi si affida solo al peso e all’indice di massa corporea (IMC) per valutare la propria salute rischia di ignorare un dato più preciso: il rapporto tra giro vita e altezza, noto come WHtR. Questo indicatore semplice da calcolare, raccomandato da diversi studi internazionali, permette di individuare con maggiore accuratezza i rischi legati all’accumulo di grasso addominale, come diabete, steatosi epatica e malattie cardiovascolari.
 Perché il rapporto giro vita/altezza è più utile dell’IMC
Perché il rapporto giro vita/altezza è più utile dell’IMC
L’IMC è uno strumento diffuso, ma ha limiti noti: non distingue tra massa grassa e massa muscolare, non considera età, sesso, etnia e soprattutto non misura dove si accumula il grasso. Il WHtR, invece, si concentra sul punto più critico: il grasso viscerale, localizzato nell’addome. È proprio questo tipo di grasso a essere associato al rischio metabolico e a numerose patologie croniche.
Il calcolo è semplice: basta dividere il proprio giro vita (in centimetri) per l’altezza (sempre in centimetri). Il valore ottenuto è un indicatore diretto del rischio.
Le soglie da conoscere: i valori che indicano rischio
Secondo il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le soglie sono queste:
• inferiore a 0,5 → rischio contenuto
• tra 0,5 e 0,59 → rischio aumentato
• superiore a 0,6 → rischio elevato
Questi valori valgono per uomini e donne adulti. In ambito pediatrico, gli stessi cut-off sono stati validati in uno studio condotto su oltre 7.000 bambini britannici: un WHtR sopra 0,5 segnala un eccesso di grasso già nell’infanzia.
Gli studi: WHtR batte IMC nella previsione di obesità e malattie
Il rapporto giro vita/altezza è stato messo a confronto con l’IMC in decine di studi clinici. Già nel 1996 era emerso che il WHtR era più affidabile nel misurare il grasso viscerale, confermato da TAC. Più recentemente, i dati della popolazione statunitense NHANES (2021–2023) hanno mostrato che il WHtR è un predittore più accurato della steatosi epatica e della fibrosi, indipendentemente da sesso ed etnia.
Un altro studio ha seguito per 15 anni circa 7.000 individui: il WHtR ha mostrato una correlazione diretta con la quantità di massa grassa misurata tramite DXA, considerata gold standard. Inoltre, nelle persone con WHtR elevato il rischio di ricovero per scompenso cardiaco era maggiore, mentre l’IMC non aveva lo stesso potere predittivo.
Perché serve anche per evitare diagnosi errate (e stigma)
Un’ulteriore forza del WHtR è la sua capacità di ridurre errori clinici e sovradiagnosi. In ambito pediatrico, per esempio, circa due terzi dei bambini classificati come sovrappeso in base all’IMC avevano invece un WHtR normale. Etichettarli come obesi avrebbe portato a interventi non necessari.
L’uso del WHtR consente anche di evitare lo stigma legato al peso. Invece di basarsi su una categoria fissa come “obeso” o “normopeso”, permette di misurare in modo oggettivo il rischio metabolico reale. Per questo, alcuni esperti propongono di parlare di “obesità clinica” o “adiposopatia”: una condizione in cui il grasso diventa metabolicamente pericoloso, anche se il peso totale non è eccessivo.
Come misurare il rapporto giro vita/ altezza – WHtR (e perché farlo regolarmente)
• Prendi un metro da sarto.
• Misura il giro vita nel punto più stretto, appena sopra l’ombelico, alla fine di un’espirazione normale.
• Misura l’altezza, senza scarpe.
• Dividi il giro vita per l’altezza.
• Se il risultato è maggiore di 0,5, potresti essere a rischio.
Esempio: 85 cm di giro vita e 170 cm di altezza → WHtR = 0,5 → sei al limite del rischio.
Conclusione: un metro può dire più della bilancia
Il rapporto giro vita/altezza è uno strumento semplice, gratuito e più efficace del peso per valutare la salute metabolica. Misurarlo regolarmente aiuta a individuare precocemente i segnali di rischio. Le linee guida internazionali e i grandi studi epidemiologici lo confermano: il WHtR è un indicatore più accurato dell’IMC, soprattutto in contesti clinici, scolastici e di prevenzione.
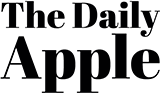

 Perché il rapporto giro vita/altezza è più utile dell’IMC
Perché il rapporto giro vita/altezza è più utile dell’IMC


